
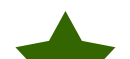 |
 |
CONFINI MENTALI |
|
Abbattere il pregiudizio per abbattere le Nazioni
Già da tempo, all’unisono, storici, sociologi, antropologi, demografi, romanzieri e statistici abbracciano la consapevolezza del fatto che il nostro pianeta é stato, sin da tempi remoti, teatro di infiniti spostamenti di gruppi migranti. E’ stimato che la sedentarietà, nel panorama di un’evoluzione umana centemillenaria, sia un’attitudine giovanissima, una vera “novità”. Fino a diecimila anni fa, prima dell’introduzione dell’agricoltura, la nostra specie ha vissuto ere di nomadismo, permanenze precarie e temporanee, movimenti (talvolta addirittura intercontinentali) ed adattamenti a nuove collocazioni, ma anche contatti e scambi con culture altre, incontri/scontri con gruppi diversi. Il mondo contemporaneo, l’avvento della civiltà agricola prima, e industriale poi, lo sviluppo del progresso e la crescita delle massificazioni culturali hanno sicuramente coronato la fine di una consuetudine, ma non certo estirpato completamente un istinto che dura dalla notte dei tempi: le migrazioni sono fenomeno rilevante anche nella nostra epoca, seppur con modalità variabili, con portata più ridotta, con incrementi legati a particolari periodi (Colonialismo di fine ‘800, primi decenni del ‘900), magari correlate a ragioni più complesse, ma che hanno come finalità ultima, oggi come ieri, la ricerca di condizioni di vita migliori. Differenze in sostanza più quantitative che qualitative; nonostante attualmente a ragioni legate al raggiungimento del benessere se ne affianchino altre, quali la fuga da situazioni di guerra, di persecuzione politica, etica, o semplicemente l’insoddisfazione generata da un’esistenza con radici in un territorio; nonostante le necessità e le possibilità dei migranti siano in sostanza mutate, all’interno di una spirale senza ritorno tesa tra globalizzazione planetaria e localismi esasperati; e nonostante, infine, i contatti con le comunità di origine siano divenuti estremamente più saldi, grazie all’esplosione dagli anni ‘50 di tecnologie e mezzi di comunicazione di massa. D’altro canto, di pari passo con il cambiamento della tendenza umana, con l’ansia del radicamento dei giorni nostri, con l’accentuazione del disorientamento e delle insicurezze personali dell’era del progresso, e la conseguente fobia dell’assenza di riferimenti esterni alla persona, un numero sempre maggiore di individui è giunto all’imprescindibilità dell’appartenenza ad un’entità con caratteristiche sentite proprie, ad un gruppo con il quale identificarsi, ad un territorio considerato in qualche modo “proprio” per diritto di nascita. La rivendicazione, insomma, di un’identità che ci si prospetta di vivere pienamente, e conseguentemente separatamente dall’altro, dal diverso, dall’estraneo, dal non appartenente. Il contatto interculturale spaventa, le differenze portano aria di cambiamento, ed il cambiamento, si sa, nel regno dello status-quò è doloroso; l’etnocentrismo dilaga, la tendenza a valutare i propri usi e costumi, i propri valori, le proprie norme, le proprie tecniche di produzione, al di sopra di quanto sia stato prodotto nel tempo e nello spazio diventa abitudine; e questo, sia chiaro, non solo nell’ Occidente, culla delle più alienanti discriminazioni, dell’annientamento di ogni alternativa all’omologazione sociale, dello sfruttamento incondizionato del sottosviluppato, dell’orgoglio ostentato della propria ricchezza economica e morale al cospetto del “Resto del Mondo”. Il fenomeno è globale, riguarda ogni continente. E così si formano gli Stati-Nazione, con il loro ossessivo legame al territorio, si rafforzano le identità nazionali di paesi “fabbricati” a tavolino per interessi politici e di dominio, si attuano mistificanti procedure pedagogiche per costruire popoli, basate su antiche Storie e Tradizioni regolarmente stravolte, quando non addirittura fortunosamente inventate. Tutto per rinvigorire quel sentimento tanto comodo ai poteri, quel focoso fardello che risponde al nome di “Patria”: il proprio essere parte di qualcosa di grande e degno di rispetto, l’eroica difesa di ciò che è accarezzato come proprio ideale. Da qui nasce l’odio nella sua forma più inutile ed ignorante, interiorizzato, giustificato, decolpevolizzato; odio mascherato attraverso il positivo e benevolo rispetto per la tradizione: solo per la propria. E la propaganda nazionalista, gli integralismi, i mezzi di comunicazione di massa, le direttive politiche e le leggi sull’immigrazione supportano il già spontaneo processo di individuazione di un nemico, e il giudizio privato finisce con l’identificare nella persona con cui si trova a contatto non un essere umano, ma a seconda delle circostanze un musulmano, un albanese, uno zingaro, un curdo, una hutu, un sikh, un “terrone”… E valori individuali al di fuori di un concetto di gruppo non contano più. Ogni singolo soggetto coincide con il gruppo al quale appartiene. Ogni interesse è rivolto al “proprio”, l’obiettività e l’autocritica svaniscono nel nulla: il disagio che l’immigrato crea in quanto corpo estraneo nell’ assoluto del “nostro” non è mai sottoposto al confronto con quello che lui stesso incontra, in un paese in cui cercando opportunità ha trovato freddezza, indifferenza, estraniamento; in cui è stato sfruttato, stuprato nelle sue potenzialità e reso con profitto consumatore di merci locali; in cui la sua vita è senza prospettive per gli stessi motivi per cui Harris, negli anni ’80, definisce gli USA un paese in guerra, riferendosi al destino riservato alle minoranze portoricane. Pregiudizi, quindi: convinzioni e credenze finalizzate alla tenace difesa di condizioni e privilegi raggiunti attraverso secoli di intolleranze. E stereotipi: rigidi concetti classificatori di persone e gruppi, non fondati su basi critiche/comparative. Tutto questo è all’ordine del giorno, e pone ostacoli alla raccolta di informazioni veritiere sulle “alterità”, attraverso la semplicità del sostenimento di giudizi così ampiamente condivisi all’interno del gruppo di appartenenza. Anche razzismo dunque; nonostante sia biologicamente provato che “parlare di razze umane è un errore: non esistono pochi gruppi distinti, ma tante piccole differenze” (G.Barbujani). Alla base di tutto una bandiera, dei confini più o meno marcati da elementi geografici, una mentalità comune; una mentalità talvolta violenta nella sua mancanza di imparzialità, in altre occasioni invece paternalista e protesa a portare esempi di civiltà tutta propria, unica. In ogni caso comunque una mentalità che presume una propria superiorità; ma, soprattutto, che ancora non ha capito che l’incontro con la diversità non va subito, o tollerato, o respinto: semplicemente, va vissuto come ovvio ed indispensabile per il futuro della razza umana; che la trasversalità culturale è l’unica possibilità che all’uomo rimane per fuggire ad un domani di ignoranza, intolleranze, poteri incontrollabili, violenze, guerre, persecuzioni, deportazioni, pulizie etniche, olocausti. E’ necessario opporre tutte le proprie forze anche al più innocente ed inoffensivo spirito patriottico, anche alla più scherzosa e banale generalizzazione fondata su principi etnici, anche al più insignificante gesto di superiorità. Perché niente di ciò che contrappone individui gli uni agli altri è realmente innocuo. Nemmeno l’inno nazionale cantato in occasione di una partita di calcio, nemmeno la cartolina del Vittoriano, nemmeno l’appello di Ciampi a tenere in casa almeno un tricolore. Le nazioni come le conosciamo ora sono invenzioni assai recenti, figlie del Risorgimento, sono proprio i piccoli ma irrinunciabili valori quotidiani a tenerle in vita. Qualcuno le ha definite un “plebiscito di ogni giorno”. Plebiscito che ha scelto la chiusura, il distacco, la disuguaglianza. Plebiscito in cui l’astensionismo diviene l’unica, salvifica soluzione. L’Alfiere |
|
| NEWS |
|
DATE CONTRASTO 2025 |
 |
 |
 |